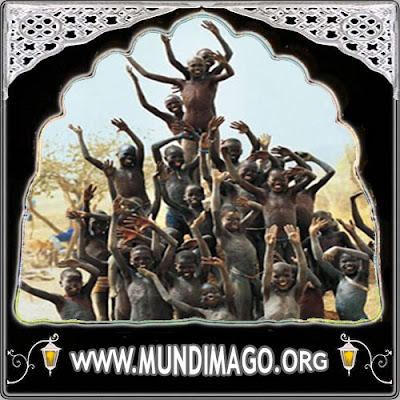.
La legge 8 novembre 2000 n. 328 all’art. 11 stabilisce che:
« i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali. »
I requisiti strutturali e organizzativi di tali strutture sono contenuti nel decreto ministeriale del Ministro per la Solidarietà Sociale del 21 maggio 2001 n. 308. Esso all’art. 3 stabilisce che le comunità che accolgono anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia impossibile o contrastante con il progetto individuale:
« devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Per le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle regioni. »
Comunità di accoglienza per minori si occupano dell'accoglienza di minori «per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia». La legge 28 marzo 2001 n. 149 (""Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"") stabilisce infatti che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, è affidato ad una famiglia.
Vengono affidati alle comunità di accoglienza anche i minori che per incuria, maltrattamento, abuso e inadeguatezza dei genitori naturali vengono minori fuori famiglia. Accolgono, inoltre, i minorenni autori di reato con progetti in alternativa alla pena detentiva e i bambini, ospitati fino al 31 dicembre 2006, negli orfanotrofi.
Molti ricorderanno quanto fosse vivo, tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, il dibattito culturale in Italia sulla necessità di orientare i servizi socio sanitari, come li chiameremmo oggi, verso la promozione e lo sviluppo della persona umana ,la tutela dei suoi diritti e come si discutessero i problemi delle istituzioni totali.
Quel dibattito ha comunque avuto grandi meriti, al di là delle contraddizioni ancora attuali, e ha prodotto importanti risultati in ambito sanitario e in ambito educativo – assistenziale.
In ambito sanitario la L. 180 sintesi del recupero del diritto alla salute e della dignità e centralità della persona ;
in ambito sociale assistenziale, educativo – (vorrei aggiungere riparativo, riabilitativo):
– ha permesso un graduale passaggio dalle strutture di grandi dimensioni a strutture più piccole che facilitassero i rapporti, non più gerarchici ed autoritari, ma educativi e d’aiuto.
– nell’ambito dei minori ai grandi istituti dove il disagio, la sofferenza, le carenze, l’annullamento della personalità erano garantiti, soprattutto se il soggiorno era di lunga durata si sono sostituiti le Comunità di piccole dimensioni.
I cambiamenti successivi sono stati molti e radicali:
– le Comunità sono diventate degli alloggi, delle case inserite nel territorio: non più grandi strutture isolate dal mondo ma nuclei inseriti in un contesto reale che mette gli utenti nella condizione di poter interagire con l’ambiente circostante;
– sono cambiati gli educatori. Si è passati da educatori “spontanei”, magari chiamati a tale missione da ideali religiosi, sociali e politici, a degli educatori “professionali”, preparati ed in grado di intervenire progettualmente in una relazione d’aiuto
Hanno avuto un grande impulso sia teorico che pratico l’adozione e l’affido famigliare.
La Comunità è un luogo educativo ambivalente, protetto ed esposto, al tempo stesso. E’ quindi coinvolto in dinamiche, interne ed esterne, molto differenti che ne condizionano le modalità d’intervento e d’esistenza.
Luogo “protetto”: perché il suo scopo resta quello di accogliere e proteggere, tutelare dei bambini in crisi, dei bambini in difficoltà offrendo loro uno spazio alternativo alla famiglia perturbata e/o perturbante quando non destrutturante.
Ma è anche un luogo “esposto”, a rischio. Non è un vaso ermetico: ma è un alambicco comunicante. Ed in quanto tale inserito, suo malgrado, in un contesto.
Il contesto non è soltanto quello sociale, ma è rappresentato anche dalle aspettative degli attori del sistema stesso.
I bambini, in primo luogo, si attendono delle cose, si immaginano la comunità in un certo modo: di solito non tanto bene. Molti pensano di essere lì per “punizione”, altri hanno ben chiaro che si tratta di un “passaggio”, tutti chiedono, in maniera più o meno conscia, una forma di “protezione”.
Poi ci sono i genitori: alcuni accettano la Comunità di buon grado per vari motivi, altri che l’attaccavano ferocemente perché la ritenevano il peggiore dei lager, specie quando era là a testimoniare della loro incapacità “genitoriale”.
Poi ci sono anche gli operatori: i giudici, gli assistenti sociali, i tecnici, gli psicologi, i neuropsichiatri, gli stessi educatori.
Ogni Comunità ha un suo universo di riferimento, un modello di funzionamento: questo è un piano del discorso non sempre chiaramente esplicitabile ed esplicitato da chi la gestisce ;se si inizia da un contesto aperto penso che sia un buon inizio,segnale che il modello cui si pensa è una figura processuale, una costellazione dinamica, una struttura in movimento.
Le comunità sono tanto cambiate ed ancora cambieranno. Dovranno cambiare se si parte dai bisogni dei bambini, dei ragazzi sotto il segno della problematicità, della ricerca, della logica induttiva che definisce la Comunità come uno spazio temporaneo di convivenza, che è una cosa ben diversa dall’istituto, dall’ospedale, dalla scuola, dalla famiglia, ma che però, essendo un luogo più complesso, può partecipare degli aspetti positivi di quegli altri modelli. E’ importante che in una Comunità ci sia capacità di contenimento, che ci sia familiarità, che ci sia organizzazione dell’attività, che ci sia cura ed aiuto per la persona, che ci sia affettività ed emozione.
La Comunità come spazio temporaneo di convivenza. La comunità come “luogo di vita”, nodo di un percorso individuale (per il minore accolto) che si fa carico delle contraddizioni della quotidianità, che entra, con coraggio e discrezione, nel vivo del disagio.
Un luogo di vita quotidiana, coi suoi riti e le sue sorprese con la consapevolezza che la costruzione di questo clima subisce “attentati” continui, la fragilità dei risultati raggiunti è evidente, i fallimenti, le frustrazioni sono un ingrediente inevitabile.
Accettare le “avventure del quotidiano” significa, al contrario, restare all’interno di una prospettiva di “probabilità/possibilità” e vedere il minore come soggetto portatore di una storia personale originale, complessa ed in evoluzione; significa essere disposti a mettere in discussione le proprie certezze e premesse in funzione delle risposte e delle attese dei bambini; costruire continuamente nuove cornici, nuove possibilità di percepire l’altro, nuovi punti d’osservazione; significa sforzarsi di cogliere le differenze, le risorse positive del minore evitando risposte stereotipate e rigide.
In ambito metodologico clinico, questo atteggiamento significa passare dalla cura come soluzione ottimale di natura “tecnico-scientifica”, al “prendersi cura di..”.
Quella stessa complessità che, in molti casi, è alla base del disagio delle famiglie d’origine e della stessa sofferenza personale dei minori E’ la fatica di reggere il gioco della flessibilità dei percorsi, delle scelte, degli atteggiamenti in un contesto disgregato che occorre fronteggiare.
La complessità delle situazioni, la varietà, la multiproblematicità, la continua trasformazione socio-economica e culturale richiedono risposte più articolate.
La Comunità dovrebbe rappresentare un nodo intermedio tra un “prima” ed un “dopo. E non uno “spazio sospeso”, un eterno presente, tanto rassicurante per i Servizi finché non esplode per eccesso di compressione.
I bambini, indipendentemente dalla gravità del loro caso, percepiscono la Comunità come soluzione temporanea: essi si interrogano sul loro futuro ed hanno bisogno di prospettive.
La temporaneità della permanenza del minore è dunque condizione essenziale per assolvere alla funzione di affidamento.
All’interno di ciascuna Comunità opera una ÉQUIPE di EDUCATORI che accompagna e condivide la quotidianità degli ospiti. Ogni quindici giorni si riunisce per programmare e organizzare il lavoro educativo.
L’attività degli educatori all’interno della Comunità è coordinata da un RESPONSABILE DI COMUNITA’, con compiti di indirizzo e sostegno al lavoro degli educatori. Spetta inoltre al Responsabile favorire i rapporti tra l’Équipe educativa e le altre figure di riferimento educativo, affettivo ed istituzionale.
L’ Èquipe educativa, per adempiere al meglio nel suo ruolo, si avvale della competenza di un SUPERVISORE (Psicologo) che si occupa di:
aiutare gli educatori nella comprensione della personalità dei Minori ospiti;
aiutare gli educatori nella gestione dei rapporti tra gli stessi e con i ragazzi;
offrire un contributo nella progettazione educativa;
fornire indicazioni ed elementi per il miglioramento della qualità del servizio offerto;
valutare con il Responsabile le esigenze di formazione interna e progettare il piano di formazione del personale;
partecipare alla valutazione delle richieste di inserimento;
seguire, quando previsti, ulteriori interventi educativi concordati dal Responsabile con i Servizi invianti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.E.I.
La valutazione di una richiesta di inserimento di un Minore fa carico all’ ÉQUIPE di ACCOGLIENZA composta da: il Responsabile, il Supervisore, il Presidente dell’Associazione o altro membro della stessa. L’autorizzazione all’inserimento di un minore in Comunità viene rilasciata dal Presidente.
Infine all’interno dell’Associazione c’è una FIGURA AMMINISTRATIVA che svolge le pratiche burocratiche e amministrative ed opera affinché vengano rispettate tutte le norme vigenti che regolamentano le Comunità e l’Associazione stessa.

Tuttavia i minori non sempre solo al sicuro nelle mure di una comunità. Abusando della sua qualità di educatrice addetta alla custodia di una comunità alloggio per minori con disturbo del comportamento, compiva atti sessuali - dicono i magistrati - con un ragazzo di età inferiore ai 16 anni, ospite della comunità. E' il terzo fermo di operatori di alcune comunità dell'Agrigentino da inizio luglio, sempre per lo stesso reato. I fatti contestati alla donna si sono verificati, secondo l'accusa, dal gennaio allo scorso 12 maggio. Poi ci sono casi di ragazzi che fuggono e tornano strafatti,ragazzi che vengono picchiati dagli educatori che non vengono licenziati ma viene trasferito il minore. Casi che il minore si rifiuta di andare a scuola e viene assecondato rischiando in seguito la bocciature per assenze ingiustificate: se lo avrebbe fatto una mamma sarebbe stata denunciata. Bambini che iniziano a fumare dove il fumo non dovrebbe esistere. Ragazzi un po' più grandicelli ma sempre minori che in libera uscita rientrano ubriachi e la cosa continua a ripetersi. In questi casi dove sono i sociali? Quindi i bambini subiscono violenze fisiche e psichiche e i loro diritti violati.
Dal settembre 2009 al maggio 2013 giudice presso il Tribunale dei minorenni di Bologna, Morcavallo ne ha visti tanti, di quei drammatici percorsi che iniziano con la sottrazione alle famiglie e finiscono con quello che lui definisce l’«internamento» (spesso per anni) negli istituti e nelle comunita` governati dai servizi sociali. Da magistrato, Morcavallo ha combattuto una guerra anche culturale contro quello che vedeva intorno a se´. Ha tentato di correggere comportamenti scorretti, ha cercato di contrastare incredibili conflitti d’interesse. Ha anche denunciato abusi e qualche illecito. E` stato a sua volta colpito da esposti, e ne e` uscito illeso, ma poi non ce l’ha fatta e ha cambiato strada: a 34 anni ha lasciato la toga e fa l’avvocato a Roma, nello studio paterno. Si occupa di societa` e successioni. E anche di diritto della famiglia, la sua passione. Il suo racconto:
"Le nostre impostazioni erano troppo diverse: io sono sempre stato convinto che l’interesse del minore debba prevalere, e che il suo restare in famiglia, la` dov’e` possibile, coincida con questo interesse. E` la linea «meno invasiva», la stessa seguita dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Gli altri giudici avevano idee diverse dalle mie, erano per l’allontanamento, quasi sempre.
Nella stragrande maggioranza dei casi si trattava di allontanamenti dalle famiglie per motivi economici o perche´ i genitori venivano ritenuti «inadeguati».
Basta che arrivi una segnalazione dei servizi sociali; basta che uno psicologo stabilisca che i genitori siano «troppo concentrati su se stessi». In molti casi, e` evidente, si tratta di vicende strumentali, che partono da separazioni conflittuali. Il problema e` che tutti gli atti del tribunale sono inappellabili perche´ si tratta di provvedimenti formalmente «provvisori». L’allontanamento dalla famiglia, per esempio, e` per sua natura un atto provvisorio. Cosi`, anche se dura anni, per legge non puo` essere oggetto di una richiesta d’appello. Insomma non ci si puo` opporre; nemmeno il migliore avvocato puo` farci nulla.
Dove si trattava di presunte violenze, una quota comunque inferiore al 5 per cento, io ho visto che molti casi si aprivano irritualmente a causa di lettere anonime. Era il classico vicino che scriveva: attenzione, in quella casa molestano i figli. Non c’era nessuna prova. Ma i servizi sociali segnalavano e il tribunale allontanava. Un arbitrio e un abuso grave, perche´ una denuncia anonima dovrebbe essere cestinata. Invece bastava a giustificare l’affido. Del resto, se si pensa che molti giudici onorari erano e sono in conflitto d’interesse, c’e` di che capirne il perche´.
Sono psicologi, sociologi, medici, assistenti sociali. Che spesso hanno fondato istituti. E a volte addirittura le stesse case d’affido che prendono in carico i bambini sottratti alle famiglie, e proprio per un’ordinanza cui hanno partecipato.
Certi fanno 20-30 udienze a settimana e incassano le parcelle del tribunale, ma intanto lavorano anche per gli istituti, le cooperative che accolgono i minori. E` un business osceno e ricco, perche´ quasi sempre bambini e ragazzi vengono affidati ai centri per mesi, spesso per anni. E le rette a volte sono elevate: ci sono comuni e aziende sanitarie locali che pagano da 200 a oltre 400 euro al giorno. Diciamo che il business e` alimentato da chi ha tutto l’interesse che cresca.
Ovviamente c’e` chi lavora in modo disinteressato. Pero` il fenomeno si alimenta allo stesso modo per tutti. I tribunali dei minori non scelgono dove collocare i minori sottratti alle famiglie, ma guarda caso quella scelta spetta ai servizi sociali. Comunque la crescita esponenziale degli affidi e delle rette e` uguale per i buoni come per i cattivi. E c’e` chi ci guadagna.
In Italia non esiste nemmeno un registro degli affidati, come accade in quasi tutti i paesi occidentali.
Sono almeno 50 mila i minori affidati: credo costino 1,5 miliardi l’anno. Forse di piu`."
Ogni ospite che risiede in una casa-famiglia costa dai 70 ai 120 euro al giorno. La retta agli istituti (sia religiosi sia laici) viene pagata dai Comuni. Soldi pubblici, dunque. Erogati fino a quando il bambino resta "in casa". Un giro d'affari che si aggira intorno a 1 miliardo di euro l'anno. Tanto ricevono le oltre 1800 case famiglia italiane per mantenere le loro "quote" di minori. Ma un bambino assegnato a una coppia è una retta in meno che entra nelle casse della comunità. E così, purtroppo, si cerca di tenercelo il più a lungo possibile. La media è 3 anni. Un'eternità. Soprattutto se questo tempo sottratto alla vita familiare si colloca nei primi anni di vita. Quelli della formazione, i più importanti per il bambino.
Anche da qui si capisce perché migliaia di coppie restano in biblica attesa che le pratiche per l'adozione o l'affido si sblocchino. Poi ovviamente ci sono anche altri fattori, la maggior parte dei quali legati alle lungaggini e alle complicazioni burocratico-giudiziarie.
Da dove nasce questo cortocircuito? Chi lucra sulla pelle di migliaia di bambini e adolescenti che provengono da situazioni difficili, molto spesso drammatiche? "
Il destino più comune per un bambino che cresce in una casa famiglia è quello di diventare un pacco. Sballottato di qua e di là, da una comunità all'altra. A volte i centri se li contendono come merce preziosa. Perché con un minore "in casa" ogni giorno piovono dal cielo rette da 70 euro a 120. Una "diaria" di cui si fa un utilizzo non esattamente "pieno". Operatori laici o suore riescono a contenere le spese facendole stare abbondantemente dentro la retta concessa dai Comuni. Quello che resta diventa liquidità a disposizione della struttura (molte case famiglia vengono mantenute con fondi messi a disposizione dal ministero della famiglia e anche grazie a donazioni private).
Quante sono le case famiglia in Italia? Chi controlla il loro operato, anche amministrativo? Le stime più recenti parlano di oltre 1800 strutture distribuite da Nord a Sud. Con alcune regioni - Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Sicilia - che raggiungono numeri più consistenti (tra le 250 e le 300). Nonostante le casse (e i relativi finanziamenti) di molti Comuni siano al verde, le case-famiglia sono in continuo aumento. Il problema è che non esiste un monitoraggio. Si conosce pochissimo di questi posti e di quello che accade all'interno. Numeri, casi, situazioni, problemi, nella maggior parte dei casi vengono portati all'esterno solo grazie alla sensibilità di qualche operatore e/o assistente sociale. Perché una banca dati c'è ma è insufficiente e non esiste un vero censimento.
Buio pesto anche sul fronte delle verifiche. "Lo Stato paga le comunità ma nessuno chiede alla comunità una giustifica delle spese - aggiunge Lino D'Andrea - . Sarebbe utile che ogni casa-famiglia rendesse pubblica le modalità con cui vengono utilizzati i fondi: quanto per il cibo, quanto per il vestiario, quanto per gli psicologi o le varie attività. Il punto è che, in assenza di informazioni, i bambini stanno in questi posti e nessuno gli fa fare niente. Non crescono, non vivono la vita, non incontrano amici, non fanno sport né gite".
Gli orfanotrofi non sono ancora scomparsi del tutto. Alcuni sono stati convertiti in case-famiglia: anche due o tre comunità nello stesso edificio. Una per piano. Poi le altre storture. Nel libero mercato delle comunità per minori abbandonati, c'è chi, per essere competitivo, abbatte la diaria giornaliera fino a ridurla a 30-40 euro. Teoricamente più la abbassi e più bambini riesci a far confluire nella tua struttura attraverso l'input dei servizi sociali che, a cascata, agiscono su indicazione del tribunale.
Altra nota dolente, i tribunali. Solo nel tribunale di Milano, ogni anno si accumulano 5 mila fascicoli relativi a famiglie disagiate con a carico almeno un minore. "I magistrati non riescono a seguire la pratiche perché i ragazzi raramente sono seguiti dal territorio di competenza - ragiona un operatore dell'infanzia - . La maggior parte sono parcheggiati in un posto senza che nessuno lo segua davvero".
Le storie che vengono a galla compongono un campionario da fare accapponare la pelle. Ma se si prova a restare lucidi, si capisce come ogni vita congelata o sfilacciata, ogni odissea che abbia per protagonista un bambino "di nessuno" si deposita sullo stesso fondo di mala amministrazione. "Le case-famiglia sono una risorsa importante per il reinserimento del minore - spiega l'avvocato Andrea Falcetta, di Roma - ma la permanenza di un bambino va gestita con cura e deve rispondere a un unico criterio: trovargli il prima possibile una collocazione familiare".
FAI VOLARE LA FANTASIA
NON FARTI RUBARE IL TEMPO
I TUOI SOGNI DIVENTANO REALTA'
OGNI DESIDERIO SARA' REALIZZATO
IL TUO FUTURO E' ADESSO .
MUNDIMAGO
http://www.mundimago.org/
.
GUARDA ANCHE